La CEDU e i limiti alle intercettazioni dirette nei confronti di giornalisti
 A proposito di Corte edu, 1 aprile 2021, Sedletska contro Ucraina
A proposito di Corte edu, 1 aprile 2021, Sedletska contro Ucraina
Se sul piano nazionale, in diversi Stati, anche europei, sono in atto limitazioni alla libertà di stampa, con mezzi diretti e indiretti, dalla Corte europea dei diritti dell’uomo arriva una sentenza che, almeno in via generale, “blinda” il diritto del giornalista a beneficiare della confidenzialità delle fonti[1].
In realtà, per Strasburgo non si tratta di un privilegio, ma di un elemento indispensabile per assicurare effettività al diritto alla libertà di stampa, da maneggiare con cura perché ogni restrizione, anche quando funzionale a garantire il segreto di Stato, può compromettere la democraticità di un Paese.
Ultima in ordine di tempo è la sentenza Sedletska contro Ucraina (ricorso n. 42634/18), depositata il 1° aprile 2021. Strasburgo ha dato torto allo Stato in causa accogliendo il ricorso di una giornalista, molto nota in patria, che era stata vittima di un provvedimento delle autorità giudiziarie nazionali con il quale era stato disposto l’accesso ai suoi tabulati telefonici.
Tra i principi affermati dalla Corte, l’obbligo per gli Stati, in base all’articolo 10 della Convenzione, di garantire la protezione delle fonti dei giornalisti in quanto “chiave di volta della libertà di stampa” che permette l’accesso a notizie riservate di interesse pubblico che la collettività ha bisogno di conoscere. Se la segretezza delle fonti non fosse assicurata, almeno in via generale, alcune persone potrebbero non rivelare notizie scottanti, con la conseguenza che al giornalista arriverebbero unicamente notizie ufficiali o che lo stesso giornalista potrebbe decidere di non pubblicarle, per timore di conseguenze penali, con effetti negativi sul tasso di democrazia di un Paese e sul ruolo di “public watchdog” dei reporter.
Va ricordato, tra l’altro, che sono in aumento le segnalazioni alla Piattaforma per la protezione del giornalismo e la sicurezza dei giornalisti, istituita dal Consiglio d’Europa, proprio per l’ingerenza nel diritto dei giornalisti alla confidenzialità delle fonti, con casi che hanno riguardato anche l’Italia[2].
La ricostruzione della vicenda all’origine della sentenza Sedletska contro Ucraina
La vicenda al centro della nuova pronuncia della Corte di Strasburgo riguardava l’accesso ai dati telefonici di una giornalista di “Radio Free Europe”, con sede a Kiev, che curava, dal 2014, un programma televisivo sulla corruzione.
L’Autorità nazionale anticorruzione aveva avviato un procedimento nei confronti di un procuratore, disponendo l’intercettazione dei dispositivi di telefonia, con ciò captando anche le conversazioni private con la partner dell’uomo intercettato. Un sito web aveva pubblicato un articolo nel quale affermava che il capo dell’Autorità anticorruzione aveva tenuto un incontro con alcuni giornalisti, svelando informazioni riservate sulle indagini e, probabilmente, permettendo ai rappresentanti dei media di ascoltare alcune registrazioni tra il procuratore e la sua compagna, che includevano questioni relative alla vita privata della coppia. La donna aveva presentato una denuncia ed era stata avviata un’indagine durante la quale era stato disposto anche l’accesso ai tabulati telefonici della cronista ucraina ricorrente.
La Corte distrettuale aveva autorizzato le intercettazioni per 16 mesi nei confronti di alcuni giornalisti e attivisti dei diritti umani. Sul piano interno, malgrado la giornalista avesse cercato di fare cessare le intercettazioni, queste erano state confermate, seppure limitate, in appello, a determinati luoghi e, successivamente l’autorizzazione era stata circoscritta alla geolocalizzazione.
Così, la giornalista si è rivolta a Strasburgo che, per la prima volta, ha anche adottato, con decisione del 18 settembre 2018, misure provvisorie – in genere riservate ai casi di estradizione verso Paesi in cui c’è il rischio di pena di morte o di trattamenti disumani o degradanti – chiedendo al Governo ucraino di fermare le intercettazioni fino alla decisione sul merito, arrivata con la sentenza del 1° aprile con la quale è stato accolto il ricorso della giornalista. Va sottolineato che l’accoglimento della richiesta di misure provvisorie quali lo stop alle intercettazioni è una prima assoluta in questo campo e potrebbe aprire la strada a una simile richiesta anche in altre occasioni.
Il giusto bilanciamento tra i diritti in gioco
Prima di passare ad esaminare il nuovo apporto della Corte europea alla tutela della segretezza delle fonti che – conviene sottolinearlo – riguardava un caso di intercettazione diretta della giornalista, va ricordato che l’articolo 10 della Convenzione europea riconosce “la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza ingerenza alcuna da parte delle autorità pubbliche e senza considerazione di frontiera”, non prevedendo espressamente il diritto di cercare informazioni incluso invece nell’articolo 19 del Patto sui diritti civili e politici del 16 dicembre 1966 in base al quale “ogni individuo ha il diritto alla liberà di espressione; tale diritto comprende la libertà di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee di ogni genere”.
La mancata previsione del diritto di cercare informazioni, che è alla base di quello a non svelare le fonti, avrebbe potuto fare pensare a una lacuna del sistema convenzionale e a una diminuzione della tutela della libertà di espressione. Tuttavia, sul punto è venuta in soccorso la Corte europea stabilendo che l’art. 10 include il diritto di cercare informazioni, che costituisce una fase essenziale per la successiva divulgazione. Correttamente, la Corte ha accantonato un’interpretazione letterale a vantaggio di una lettura dell’articolo 10 volta a garantire l’effettiva realizzazione del diritto attivo di informare e passivo di ricevere le informazioni.
È opportuno ricordare il leading case a cui è collegato il diritto alla segretezza delle fonti rappresentato dalla sentenza Goodwin contro Regno Unito del 27 marzo 1996 (ricorso n. 17488/90). In quell’occasione, Strasburgo ha stabilito che vanno garantiti alcuni “privilegi” ai giornalisti che, divulgando notizie di interesse generale, spesso scottanti, svolgono il ruolo di watchdog che è centrale per la democrazia, a sua volta essenziale per l’effettiva realizzazione di ogni diritto convenzionale. È evidente che il diritto di informare presuppone quello di cercare informazioni per lo più da fonti non ufficiali che possono condizionare la comunicazione al giornalista alla garanzia di anonimato. In caso contrario, non solo il giornalista non potrebbe svolgere la sua attività, ma la collettività non sarebbe informata su questioni di interesse generale.
Pertanto, per la Corte, la protezione delle fonti giornalistiche ha un’importanza capitale per l’esercizio effettivo della libertà di espressione. Si può pensare, a tal proposito, ai casi in cui un giornalista riceva informazioni sulla corruzione di uomini politici da fonti che vogliono mantenere l’anonimato: se le divulgasse, senza la possibilità di avvalersi del diritto di non svelare la fonte, correrebbe il rischio di gravi conseguenze sulla sua attività, che potrebbero spingerlo a non rivelare fatti danneggiando l’intera collettività. La tutela della confidenzialità delle fonti è stata poi confermata in numerose sentenze e ha incluso sia le ingerenze dirette (come ad esempio la richiesta del nome della fonte al giornalista) sia ingerenze indirette come il sequestro di dispositivi elettronici o documenti.
Per citare solo le più importanti, basti ricordare la pronuncia del 22 novembre 2007, Voskuil contro Paesi Bassi, ricorso n. 64752/01, con la quale la Corte europea ha ritenuto che fosse stato violato il diritto del ricorrente alla libertà d’informazione garantito dall’art. 10, in quanto il giornalista era stato arrestato per essersi rifiutato di svelare la fonte – che serviva agli inquirenti per individuare gli autori di un grave reato – all’origine di un articolo riguardante un’inchiesta sul traffico d’armi.
Già in quell’occasione, la Corte ha precisato che non hanno rilievo le modalità con le quali la fonte abbia ottenuto le informazioni, non chiedendo così al giornalista di distinguere nell’acquisizione delle notizie (si vedano anche le sentenze Financial Times Ltd e altri contro Regno Unito, del 15 dicembre 2009, ricorso n. 821/03; Sanoma Uitgevers B.V. contro Paesi Bassi, del 14 settembre 2010 ricorso n. 38224/03; Görmüs e altri contro Turchia, del 19 gennaio 2016, ricorso n. 49085/07; Becker contro Norvegia, del 5 ottobre 2017, ricorso n. 21272/12). Non manca poi una pronuncia della Grande Camera come la sentenza del 14 settembre 2010, nel caso Sanoma Uitgevers B.V. contro Paesi Bassi, ricorso n. 38224/03[3].
Ricostruendo in breve gli approdi della Corte europea, si può sottolineare che Strasburgo considera come regola generale la protezione delle fonti del giornalista sia da ingerenze dirette – come nei casi di interrogatorio o di intercettazioni delle utenze – sia indirette, attraverso il sequestro di materiale e documentazione in possesso del giornalista, inclusi i dispositivi informatici (si veda il caso Tillack contro Belgio, sentenza del 27 novembre 2007, ricorso n. 20477/05).
La Corte ha affermato il carattere eccezionale degli interventi delle autorità giudiziarie volte a ottenere informazioni sull’identità delle fonti, con il riconoscimento di un privilegio che non può essere diminuito solo perché il giornalista ricorre a stratagemmi per ottenere notizie di interesse collettivo. Così, con la sentenza del 12 aprile 2012 nel caso Martin e altri contro Francia (ricorso n. 30002/08), la Corte europea ha stabilito che la protezione delle fonti “è una delle pietre angolari della libertà di stampa” in quanto l’assenza di protezione “potrebbe dissuadere le fonti dei giornalisti dall’aiutare la stampa a informare il pubblico su questioni di interesse generale”. Anche la protezione delle fonti ha così, nella visione della Corte, un duplice rilievo: per il giornalista che svolge la sua funzione e per la collettività che viene a conoscenza di informazioni di interesse generale.
Intercettazione diretta dei giornalisti ed onere della prova sulle autorità nazionali
Resta da chiedersi cosa ha aggiunto la Corte nella pronuncia del 1° aprile 2021, nella quale, accertata l’esistenza di un’ingerenza, prevista dalla legge e dallo stesso articolo 10 poiché funzionale a un fine legittimo come la prevenzione di un reato e la tutela della reputazione altrui, ha rilevato che la misura non era necessaria in una società democratica. La Corte, da un lato, non fa che confermare i precedenti approdi rilevando che la protezione delle fonti riveste un’importanza fondamentale e che eventuali limitazioni devono essere trattate con la massima attenzione e ammesse solo in presenza di un bisogno sociale imperativo.
Per la Corte, infatti, il diritto del giornalista a non rivelare le fonti e a godere della loro segretezza “non può essere considerato come un mero privilegio da concedere o togliere sulla base della legittimità o illegittimità delle fonti, ma esso è una parte e un segmento del diritto ad informare, da trattare con la massima attenzione”. La Corte, dall’altro lato, aggiunge un ulteriore elemento che va a rafforzare la tutela delle fonti perché sottolinea che non è il raggiungimento del risultato voluto dalle autorità inquirenti ad essere in contrasto con la Convenzione, ma proprio lo strumento perché, anche nei casi in cui le autorità non arrivino a individuare la fonte, l’accesso a materiale essenziale per il giornalista comporta una violazione del diritto alla libertà di stampa. Spetta poi alle autorità nazionali dimostrare la proporzionalità della misura.
E su questo punto ci sembra che la Corte abbia tenuto a sottolineare il rilievo dell’onere della prova che grava sulle autorità nazionali che intervengono incidendo sulla protezione delle fonti. Così, la Corte ha evidenziato che i rischi si verificano quando sono disposti controlli sulle utenze telefoniche dirette del giornalista perché gli inquirenti potrebbero individuare numerose fonti, non solo quelle necessarie a un particolare caso. E’ posto, così, un freno quasi generale nell’utilizzo di misure, come le intercettazioni, che non permettono di delimitare a una singola fattispecie rilevante l’acquisizione di dati, fornendo uno scudo alle ingerenze di questo tipo.
In questo modo si concretizza una forte presunzione verso la protezione delle fonti dei giornalisti e la necessità che limiti a detta protezione possano essere ammissibili solo tenendo conto del fine delle misure ossia l’esistenza di un bisogno sociale imperativo accompagnato da misure di salvaguardia per limitare all’essenziale l’ingerenza ed evitare che le informazioni attinte dall’utenza del giornalista finiscano nelle mani di più persone.
C’è in ultimo da chiedersi se una differenza possa essere fatta tra ingerenze dirette sul giornalista o che si realizzino in via indiretta, ad esempio intercettando altri.
A nostro avviso, va tenuto conto che la limitazione alla libertà di stampa, con mezzi diretti o indiretti, è un’eccezione da interpretare sempre in modo restrittivo. Se, però, nel caso dell’intercettazione diretta la presunzione sulla classificazione di tale misura come limitazione della libertà di stampa è quasi assoluta, nei casi di intercettazione di altri rimane un maggiore margine di intervento degli Stati, fermo restando l’onere della prova su dette autorità.
Questo si desume, a nostro avviso, dalla sentenza Big Brothers Watch e altri contro il Regno Unito depositata il 13 settembre 2018, ricorso n. 58170/13 e altri (oggi dinanzi alla Grande Camera) nella quale la Corte ha rilevato che la serietà dell’ingerenza va valutata tenendo conto della circostanza che l’intercettazione abbia riguardato direttamente il cronista o piuttosto terzi. In questi casi, la serietà dell’ingerenza diminuisce, ma gli Stati devono comunque adottare misure per impedire che le fonti dei giornalisti siano divulgate, con la conseguenza che, seppure implicitamente, la Corte chiede sempre alle autorità nazionali la previsione di misure per tutelare i giornalisti nell’esercizio delle proprie attività.
In questa direzione ci sembra vada anche la decisione del 29 giugno 2006, Weber e Saravia contro Germania, ricorso n. 54934/00, nella quale, con riguardo a un sistema di monitoraggio non rivolto a una specifica persona, la Corte ha sottolineato che nel caso in esame “Surveillance measures were, in particular, not directed at uncovering journalistic sources” e, quindi, “The interference with freedom of expression by means of strategic monitoring cannot, therefore, be characterised as particularly serious”.
Invece, nella sentenza del 1° aprile 2021, a fronte di un’intercettazione diretta e prolungata di una giornalista, la Corte ha concluso che la misura era sproporzionata rispetto al fine perseguito – che era quello di individuare l’autore della fuga di notizie su un caso di corruzione – e che i giudici ucraini non hanno utilizzato i parametri di Strasburgo, non dimostrando in che modo la geolocalizzazione servisse a combattere gravi crimini e neppure fornendo elementi per provare di aver fatto ricorso ad altri mezzi meno invasivi. Un punto così ci sembra consolidato anche guardando alla sentenza del 6 ottobre 2020 nella causa Jecker contro Svizzera (ricorso n. 35449/14): la sola circostanza che l’ordine di divulgazione della fonte serva per individuare l’autore del reato non può giustificare la mancata protezione delle fonti[4].
Pertanto, per Strasburgo, le autorizzazioni alle intercettazioni del telefono della giornalista e l’acquisizione dei tabulati telefonici sono state gravemente lesive della libertà di stampa e misure ampliamente sproporzionate. Accertata la violazione dell’articolo 10, la Corte ha anche condannato lo Stato in causa a pagare 4.500 euro per i danni non patrimoniali subiti dalla giornalista e 2.350 euro per le spese processuali.
Note
[1] Cfr. M. Castellaneta, Segretezza delle fonti giornalistiche nel quadro della CEDU. Una nuova pronuncia della Corte di Strasburgo, in questa Rivista, 2020, https://www.giustiziainsieme.it/it/europa-e-corti-internazionali/1367-articolo-ceduarticolo-cedu; D. Banisar, Silencing Sources: an International Survey of Protections and Threats to Journalists’ Sources, reperibile nel sito http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1706688; G.E. Vigevani, La libertà di manifestazione del pensiero, in G.E. Vigevani – O. Pollicino – C. Melzi d’Eril – M. Cuniberti – M. Bassini (a cura di), Diritto dell’informazione e dei media, Torino, 2019, p. 3 ss.; Id., L’informazione e i suoi limiti: il diritto di cronaca, ivi, p. 25 ss.; R. Chenal, Il rapporto tra processo penale e media nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, in Diritto penale contemporaneo, 2017, n. 3, p. 37 ss., reperibile nel sito http:///www.penalecontemporaneo.it; M. Oetheimer, A. Cardone, Articolo 10, in Commentario breve alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, a cura di S. Bartole, P. De Sena, V. Zagrebelsky, Padova, 2012, p. 397 ss.; G. Resta, La giurisprudenza della Corte di Strasburgo sulla libertà d’informazione e la sua rilevanza per il diritto interno: il caso dei processi mediatici, in Dir. inf. e inf., 2012, p. 163 ss.; Id., Trial by Media as a Legal Problem, Napoli, 2009; M. Lemonde, Justice and the media, in European Criminal Procedures, a cura di M. Delmas-Marty, J.R. Spencer, Cambridge, 2002, p. 688 ss.
[2] Nel sito è riportata anche la segnalazione sulle intercettazioni disposte nel corso di un’indagine della Procura di Trapani sul ruolo di alcune organizzazioni non governative nel traffico di migranti. Seppure non in via diretta, stando a quella che risulta fino ad oggi, l’intercettazione di alcuni attivisti ha portato anche alla trascrizione di comunicazioni con i giornalisti. Si veda l’alert presente nella piattaforma https://www.coe.int/en/web/media-freedom/.
[3] Per un esame delle sentenze della Corte di Strasburgo rinviamo a M. Castellaneta, La libertà di stampa nel diritto internazionale ed europeo, Bari, 2012.
[4] V. M. Castellaneta, Segretezza delle fonti giornalistiche nel quadro della CEDU. Una nuova pronuncia della Corte di Strasburgo, in questa Rivista, 2020, https://www.giustiziainsieme.it/it/europa-e-corti-internazionali/1367-articolo-ceduarticolo-cedu.
Fonte: Giustizia Insieme
*****
Segretezza delle fonti: la Corte europea blocca le intercettazioni a danno dei giornalisti
Trackback dal tuo sito.

 Finanzia la realizzazione di progetti di video inchieste su temi di cronaca nazionale e internazionale. Si rivolge a giovani giornalisti, free lance, studenti e volontari dell’informazione.
Finanzia la realizzazione di progetti di video inchieste su temi di cronaca nazionale e internazionale. Si rivolge a giovani giornalisti, free lance, studenti e volontari dell’informazione.
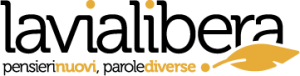 Un nuovo progetto editoriale e un bimestrale di Libera e Gruppo Abele, LaViaLibera eredita l'esperienza del mensile Narcomafie, fondato nel 1993 dopo le stragi di Capaci e via D'Amelio.
Un nuovo progetto editoriale e un bimestrale di Libera e Gruppo Abele, LaViaLibera eredita l'esperienza del mensile Narcomafie, fondato nel 1993 dopo le stragi di Capaci e via D'Amelio.
 Articolo 21: giornalisti, giuristi, economisti che si propongono di promuovere il principio della libertà di manifestazione del pensiero (oggetto dell’Articolo 21 della Costituzione italiana da cui il nome).
Articolo 21: giornalisti, giuristi, economisti che si propongono di promuovere il principio della libertà di manifestazione del pensiero (oggetto dell’Articolo 21 della Costituzione italiana da cui il nome).